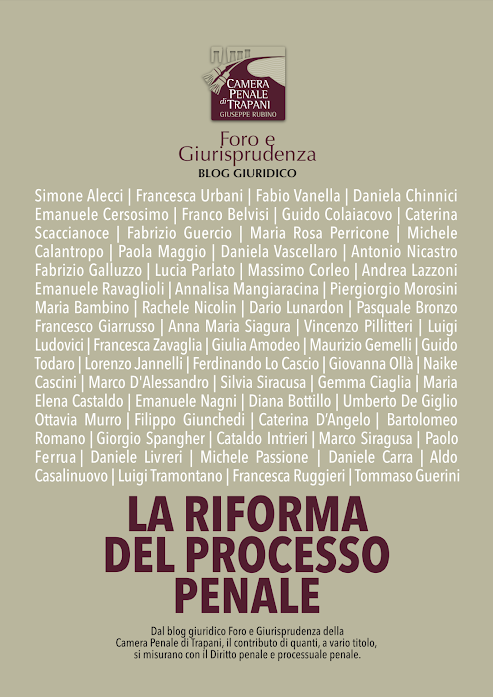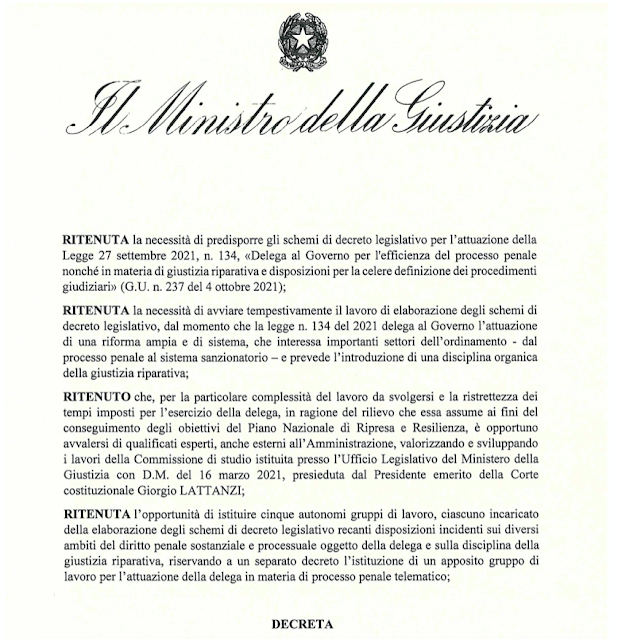Concludiamo l’opera della quale da qualche mese ci stiamo occupando sulla riforma del processo penale.
Lo abbiamo fatto, sin dal testo Bonafede, per sezioni e con il metodo dell'intervista, con poche domande rivolte a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e ad un docente universitario.
Abbiamo pubblicato i contributi secondo l'ordine di ricezione, in maniera casuale. Il piano completo dell'opera è consultabile al → link.
Terminate le varie sezioni abbiamo pubblicato tutte le risposte di tutti i professionisti del processo in un unico contributo.
Concludiamo oggi oggi con la sezione La riforma della procedibilità e delle contravvenzioni, per la quale abbiamo rivolto le nostre domande a Marco D'Alessandro (giudice), Silvia Siracusa (pm), Gemma Ciaglia (avvocato), Maria Eelena Castaldo e Emanuele Nagni (docente).
1. L’art. 8 del disegno di legge introduce la procedibilità a querela per il reato di lesioni stradali gravi, condivide questa riforma e se sì non le pare un’occasione mancata per estendere a molti altri reati tale condizione di procedibilità?
Il Giudice: IN RELAZIONE ALL’ART. 8, RIGUARDANTE LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’, IL MIO MODESTO PARERE E’ QUELLO DI NON ABOLIRE LA PERSEGUIBILITA’ DI UFFICIO CHE COSTITUISCE IN OGNI CASO UN VALIDO DETERRENTE NEI CONFRONTI DI CHI PROVOCA LESIONI GRAVI (O GRAVISSIME) NELLE CONDIZIONI E CON LE MODALITA’ INDICATE NELL’ART. 590 BIS C.P.; TALI COMPORTAMENTI VANNO SANZIONATI A PRESCINDERE DALL’EFFETTIVA VOLONTA’ DELLA PERSONA OFFESA.QUANTO INDICATO NELLA LETTERA B) DEL MEDESIMO ARTICOLO E’ CONDIVISIBILE, PER L’EVIDENTE RISPARMIO DI TEMPO E DI SPESE PER L’ERARIO CHE NE POTREBBE DERIVARE.
Il PM: Posto che la ratio della legge n.41 del 2016 - delineando nell’art. 590 bis c.p. non già forme circostanziate dell’illecito di cui all’art. 590 c.p. bensì un autonomo delitto di lesioni personali stradali, gravi (cioè con un riconoscimento di prognosi superiore a gg. 40) o gravissime, perseguibile d’ufficio sia nell’ipotesi base di cui al comma 1, caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sia nelle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi - è stata indubbiamente quella di inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati ritenuti di particolare allarme sociale, prima di esprimere la mia opinione su ciò che mi viene richiesto, ritengo opportuno operare un distinguo a mio avviso indispensabile. L’ipotesi base è certamente connotata da un minore disvalore della condotta e del grado della colpa rispetto a quelli delle più gravi ipotesi di cui ai commi successivi, caratterizzate dalla consapevole assunzione di rischi irragionevoli; basta considerare che, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di lesioni colpose provocate con totale esclusione della volontarietà dell’evento da parte dell’autore della condotta.
Il primo comma racchiude, inoltre, diverse fattispecie in cui il soggetto attivo non deve essere necessariamente il conducente di un veicolo a motore (si pensi a chi guida una bicicletta o altro analogo mezzo di trasporto) e che hanno come presupposto la violazione di una qualsiasi norma del codice della strada diversa da quelle contemplate nei commi successivi.
Anche la Corte Costituzionale - pur non ritenendo fondate le diverse questioni di legittimità sollevate con riferimento al regime della procedibilità dell’art. 590 bis c.p. - ha comunque ritenuto auspicabile un intervento finalizzato a rendere procedibile a querela tutte le ipotesi contemplate nell’articolo in oggetto con la sola esclusione di quelle di cui al comma 2. I giudici delle leggi hanno infatti posto l’accento sul profilo di un’evidente disparità di trattamento tra il reato di lesioni stradali, procedibile d’ufficio da marzo del 2016, e quello di lesioni in ambito sanitario laddove, anche se più gravi o maggiormente incisive nella sfera della salute dell’individuo, sono comunque procedibili a querela di parte; siffatto differente regime di procedibilità è ancora meno plausibile se si considera che la responsabilità in ambito sanitario è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che comunque non hanno inciso sulla procedibilità.
Fatta questa doverosa premessa, ritengo di condividere la proposta - inserita nel progetto di legge attualmente all’esame della Commissione giustizia della Camera - di modificare la norma penale riconducendo nell’alveo della procedibilità a querela di parte anche il reato di lesioni colpose gravi commesse in ambito stradale mantenendo l’esclusione per quelle gravissime e ciò in un‘otticachiaramente deflattiva e di utilizzo dell’espediente penale solo ove voluto.
A mio avviso deve essere dunque ripristinata la possibilità per la persona offesa di azionare un procedimento penale solo dietro presentazione di un atto querelatorio per evitare il paradosso che nonostante una serie di variabili entrate in gioco (quali ad esempio un intervenuto risarcimento del danno cagionato e/o la volontà di rimettere la querela da parte del danneggiato) - che di fatto possono rendere non più necessario e/o opportuno l’esercizio dell’azione penale - il procedimento debba comunque andare avanti.
Certo è anche vero che, allo stato attuale, esistono altri validi strumenti di definizione anticipata e celere nelle ipotesi di conclamata lievità quali l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.p. - in realtà poco utilizzato almeno nella prassi giudiziaria palermitana - ovvero nei casi meno lievi una richiesta di sospensione per messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p., strumenti questi che consentono una definizione con estinzione al ricorrere di determinati presupposti; tuttavia, ripristinando la procedibilità a querela di parte nell’ipotesi di cui all’art. 590 bis c.p.,si verrebbe ad evitare la messa in moto del meccanismo procedimentale penale con evidente dispendio di energie e di tempo.
Analogamente ritengo sarebbe stato opportuno estendere siffatta modifica legislativa anche ad altre fattispecie di reato perseguibili d’ufficio come ad esempio quei reati contravvenzionali in cui sia possibile individuare una persona offesa titolare del diritto di proporre querela (quali ad esempio le ipotesi previste dagli artt. 659, 660 e 674 c.p.) anche se è pur vero che il regime di procedibilità d'ufficio è il connotato comune a tutte le contravvenzioni laddove soltanto per i delitti è possibile distinguere il regime di procedibilità a querela da quello d'ufficio in ragione dell'incidenza su interessi disponibili o meno. La stessa Corte Costituzionale - pur concludendo per la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al regime di procedibilità dell’art. 660 c.p. - non ha mancato di rilevare come possa apparire inattuale ricomprendere nella contravvenzione in esame le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, segnalando incidentalmente l'opportunità di un intervento legislativo in materia.
Per quanto attiene invece ai delitti, il decreto legislativo n. 36/2018 (“Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettera a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n.103”) ha già operato una trasformazione di taluni reati procedibili d’ufficio in reati a querela; nello specifico, sono state colpite da tale modifica quelle fattispecie criminose che si caratterizzano per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo e, dunque, di minore allarme sociale (a titolo esemplificativo i reati contro la persona che sono puniti con la sola pena pecuniaria o detentiva, non superiore ai 4 anni). Per le altre tipologie di reato di particolare allarme sociale invece mi sembra corretto ed opportuno mantenere l’attuale regime di procedibilità d’ufficio.
L'Avvocato: La sostituzione dell’attuale procedibilità d’ufficio delle lesioni personali gravi commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale con la procedibilità a querela di parte rappresenta un chiaro indicatore della finalità deflattiva perseguita dal legislatore. Lo sforzo è apprezzabile, non solo per fronteggiare la pressione in termini quantitativi che tale tipologia di reati esercita sul lavoro degli Uffici di Procura ma soprattutto in considerazione della portata offensiva del reato, con particolare riguardo all’entità della lesione.
Risulta condivisibile la decisione di non estendere siffatta modifica alle lesioni gravissime, attesa la difficoltà di coniugare le lesioni colpose più gravi con una perseguibilità rimessa alla valutazione della persona offesa dal reato.
Opportuna potrebbe essere l’introduzione di un termine più lungo di quello ordinario per la proposizione della querela, conservando altresì la competenza del Tribunale (in composizione monocratica) anche per le ipotesi connotate dalla procedibilità a querela.
Nonostante il substrato certamente positivo, la natura puntiforme della riforma, limitata quasi in maniera chirurgica a un singolo aspetto, ne costituisce un evidente vulnus, profilandosi come (l’ennesima) occasione mancata per un’ampia valutazione di sistema che, agendo per macro-categorie di reato, individuasse la ratio comune sottesa alla modifica del regime di procedibilità per plurime fattispecie, nel contempo effettuando un vaglio più incisivo in termini di depenalizzazione, che avrebbe potuto ad esempio riguardare le lesioni lievi e lievissime (stradali e non).
Il Docente: Ad avviso degli scriventi, il principio direttivo della delega di cui alla lett. a) dell’art. 8 del disegno di legge A.C. 2435 sembrerebbe ragionevolmente conformarsi ai propositi di revisione dell’esecutivo, per quanto in modo prudente. Come noto, stando alla Relazione illustrativa della riforma, l’obiettivo principale consiste nel ripristinare una risposta più veloce ed efficiente del processo penale, garantendo efficacemente il bilanciamento fra l’azione giudiziaria e il rispetto dei diritti di difesa. Pertanto, un intervento in termini di procedibilità a querela per il delitto di lesioni personali stradali gravi, previsto dal 1° comma dell’art. 590-bis c.p., è da ritenere certamente auspicabile. Ciò risulta ancor più evidente se si pone mente alla sentenza n. 223 del 25 settembre 2019, in cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (emesso in attuazione della delega contenuta all’art. 1, 16° comma, lett. a) e b) della L. 23 giugno 2017, n. 103), sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., dal Tribunale ordinario di La Spezia con l’ordinanza dell’8 ottobre 2018. Atteso che la Consulta non ha accolto una simile modifica additiva, tenendo salva la procedibilità d’ufficio del 1° comma dell’art. 590-bis c.p., appare doverosa un’iniziativa del Governo che torni sul punto, guardandosi bene dall’inserire nel correttivo anche le lesioni gravissime. Chiaramente, la procedibilità a querela avrebbe potuto investire anche diverse altre fattispecie di reato, ma non stupisce che l’esecutivo al momento circoscriva il suo intervento ad impedire l’instaurazione di procedimenti non certo poco costosi e tantomeno sporadici nel nostro Paese. È inutile nascondere che le perizie intraprese per una necessaria ricostruzione del sinistro stradale oggi gravano molto – non solo in termini di tempo, ma anche di costi – sul carico processuale. In effetti, un simile aggravamento non può più certo ammettersi se la persona offesa non dimostri il proprio interesse di procedere all’istanza punitiva dell’autore del fatto
2. Il medesimo articolo prevede la remissione tacita della querela in caso di ingiustificata omessa comparizione a dibattimento della persona offesa citata a testimoniare. Quale il suo giudizio al riguardo?Il Giudice: CONDIVIDO ANCHE IL “POTENZIAMENTO” DEFLATTIVO CHE POTREBBE DERIVARE DALL’INTRODUZIONE, IN AGGIUNTA ALLA MANCATA COMPARIZIONE SIN DALLA PRIMA UDIENZA DEL QUERELANTE (GIA’ OGGETTO DI ARRESTI DELLA SUPREMA CORTE ANCHE IN CONSESSO PLENARIO), ANCHE DELLA SUA ASSENZA ALL’UDIENZA FISSATA PER LA SUA AUDIZIONE, PER VALUTARE LA SUSSISTENZA DELLA CD. REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA; MA NON PER TUTTE LE IPOTESI DI REATO PERSEGUIBILE A QUERELA PERO’, POICHE’ ALCUNE FATTISPECIE (QUALI AD ESEMPIO IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI) DEBBONO MANTENERE UNA STRUTTURA SANZIONATORIA ADEGUATAMENTE RIGIDA;
Il PM: Condivido pienamente questa previsione rappresentando che peraltro è già una prassi consolidata presso il Tribunale di Palermo procedere in tal senso limitatamente ai reati contro il patrimonio (nella specie truffa ed appropriazione indebita) e con lo specifico avvertimento che l’eventuale assenza della persona offesa regolarmente citata senza addurre un legittimo impedimento viene valutata dal giudicante quale remissione tacita della querela.Ritengo che l’assenza ingiustificata in dibattimento di una persona offesa - che a suo tempo ha deciso di azionare un procedimento penale per far valere i suoi diritti ed ottenere, se del caso, anche un ristoro dei danni - debba essere considerata quale comportamento concludente di una sopravvenuta volontà di non volere più perseguire penalmente l’autore di quella determinata fattispecie delittuosa commessa in suo danno.
Tutto questo avrebbe un’indubbia valenza deflattiva e andrebbe a beneficio della celerità e dell’economia dibattimentale in ossequio al principio della ragionevole durata del processo consacrata, come noto, dall’art. 111, comma 2, Cost.
Anche la Suprema Corte, di recente, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”; secondo i giudici di legittimità, dunque, perché possa essere validamente considerata una tacita remissione della querela è indispensabile che il querelante sia stato preventivamente avvisato delle conseguenze giuridiche del comportamento omissivo e benché siffatto avvertimento non sia espressamente previsto in nessuna disposizione normativa rappresenta una prassi non solo del tutto “legittima” bensì persino “auspicabile” al fine di rafforzare le esigenze informative della persona offesa.
Analogamente, qualora il querelato - previamente avvertito dal giudicante in ordine al significato della sua mancata comparizione - non si presenti alla udienza di comparizione si dovrebbe presumere da tale atteggiamento che il predetto non abbia intenzione di ricusare la remissione della querela e che, quindi, intenda “accettare” tale remissione e le relative conseguenze (emissione di sentenza a non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato). Gli avvisi da parte del giudice sono finalizzati, nella sostanza, a far emergere l’eventuale venir meno del “perdurante interesse della persona offesa all’accertamento delle responsabilità penali” e permettono di escludere “sin dalle prime battute lo svolgimento di sterili attività processuali destinate a concludersi comunque con un esito di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato”.
L'Avvocato: La disposizione consente di risolvere la stagnazione sul ruolo giudiziario di una miriade di processi - spesso incardinati a seguito di reati c.d. bagattellari – rinviati a più riprese proprio in ragione dell’assenza della persona offesa-testimone. D’altro canto, l’aver agganciato la remissione tacita di querela alla mera mancata comparizione della persona offesa sembra porsi in contrasto con l’insegnamento della Corte di Cassazione che ha ripetutamente evidenziato come l’abdicazione dalla pregressa istanza punitiva deve necessariamente ricavarsi dalla combinazione tra la condotta omissiva e il previo formale avvertimento del significato che ad essa viene attribuito. Con il rischio di far discendere dalla nuova previsione automatismi pregiudizievoli per la persona offesa, di cui non venga positivamente accertata la libera e consapevole scelta di disinteressarsi del processo da lei stessa sollecitato.
Il Docente: La proposta di cui all’art. 8, 1° comma, lett. c) del disegno di legge, per quanto sia di fondamentale rilevanza per ottemperare alle esigenze di semplificazione e speditezza del processo penale, appare però molto lontana dal suscitare un sentimento di stupore in chi scrive. La direttiva del delegante si caratterizza in modo certamente funzionale ad assicurare la volontà seria e concreta della persona offesa di portare avanti l’istanza punitiva perseguita in sede di querela, ma la portata della nuova disciplina non sembra possa assumere una connotazione rivoluzionaria. Invero, prevedere la remissione tacita della querela nell’ipotesi di ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale in cui assume l’ufficio di testimone non rappresenta altro che un’estensione positiva e, dunque, vincolante di un principio di diritto già diffusamente applicato nella prassi processuale. In effetti, secondo quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31668 del 23 giugno 2016, qualificare come incompatibile con la volontà di persistere nella querela l’eventuale assenza all’udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice era ormai, da alcuni anni e in ottica giurisprudenziale, una consuetudine già consolidata nelle aule di giustizia.
3. L’art. 9 riduce il criterio di ragguaglio tra le pene detentive e quelle pecuniarie dagli attuali 235 euro al giorno a 180 euro. Non le pare un tasso di conversione troppo alto, se si aspira davvero a “deflazionare, incassando”?
Il Giudice: IN RELAZIONE ALL’ART. 9, CONCORDO PIENAMENTE SUL FATTO CHE I CRITERI DI RAGGUAGLIO DELLE PENE DETENTIVE CON QUELLE PECUNIARIE DEBBANO ESSERE RAPPORTATI AL’EFFETTIVA SITUAZIONE CONGIUNTURALE CHE SI STA VIVENDO IN QUESTO PERIODO E PERTANTO RIDOTTI NEL LORO IMPORTO A NON PIU’ DI €150,00.
Il PM: Si lo ritengo certamente un tasso di conversione troppo elevato, per non dire esoso, come tale inaccessibile alla stragrande maggioranza dei soggetti che si trovano ad affrontare un processo penale in veste di imputato. Ne è prova il fatto che nelle aule giudiziarie palermitane di rado si sceglie di definire la posizione con una conversione della pena detentiva eventualmente da infliggere, sola o congiunta a pena pecuniaria, in quanto siffatto meccanismo risulta assai oneroso e ciò in evidente contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale e di finalità rieducativa della pena di cui agli articoli 3 co. 2 e 27 co. 3 della Costituzione. Secondo l’originaria previsione, il ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria avrebbe dovuto evitare a quei soggetti ritenuti responsabili di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi per potere impostare un reale percorso riabilitativo ma sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo scaturenti dall’ingresso in carcere mentre, di fatto, si è trasformato in un privilegio per i soli condannati abbienti. La stessa Consulta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo evidenziando come la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sia diventata eccessivamente onerosa per molti condannati e segnalando, quindi, l'opportunità di revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale “nella consapevolezza che soltanto una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una commisurazione da parte del giudice proporzionata tanto alla gravità del reato quanto alle condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi l’effettiva riscossione”, possa costituire una seria alternativa alla pena detentiva. Sarebbe dunque opportuno operare un rinvio non solo all’art. 133 ter (in materia di rateizzazione della pena pecuniaria) ma anche all'art. 133 bis per consentire al giudice di adeguare, nel caso concreto, l’ammontare della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva alle condizioni economiche effettive del reo, aumentandola o riducendola sino ad un terzo, nel rispetto dei criteri di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza, nonché di finalismo rieducativo della pena irrogata.
L'Avvocato: La riduzione di € 55/die rischia di rendere poco efficace il principio ispiratore sotteso alla modifica, lasciando l’importo a soglie ancora significative (€ 180).
Il Docente: In realtà, sembrerebbe solo secondo un’analisi ictu oculi della proposta normativa che l’art. 9 del disegno di legge possa remare contro il principio “deflazionare, incassando”. A parere degli scriventi, la correzione nel ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive della sostituzione con un importo «non superiore a 180 euro» dell’attuale criterio di 250 euro per ogni giorno di pena detentiva non risulta proprio una contraddizione delle istanze di contrasto all’ingente mole di lavoro che quotidianamente intasa la macchina della giustizia. Effettivamente, una simile previsione promuoverebbe ancor di più il ricorso alle sanzioni sostitutive che, come noto, non perseguono alcuna finalità di risocializzazione del reo, avendo invece il precipuo scopo di frenare – attraverso la tipica ‘vis’ retributiva – la desocializzazione che spesso si presenta a seguito dell’esecuzione di una pena limitativa della libertà personale di breve durata. Del resto, del medesimo avviso si è recentemente dimostrata anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 15 dell’11 febbraio 2020, in cui il legislatore è stato sensibilizzato alla restituzione di una pena pecuniaria sempre più effettiva, non solo nel superamento degli obsoleti strumenti di esecuzione forzata, ma anche intervenendo con misure di conversione di pene detentive. Inoltre, un ritocco di tal sorta potrebbe persino agevolare il ricorso ai riti alternativi come l’applicazione della pena su richiesta delle parti. D’altronde, è ormai di pubblica diffusione – oltre che suffragato da numerose risultanze statistiche – il sospetto che il congestionamento senza sosta del carico giudiziario italiano sia dovuto anche allo scarso successo che i riti alternativi consensuali ogni giorno riscuotono nella pratica. Tuttavia, il maggior dubbio suscitato dalla direttiva dell’art. 9 scaturisce dalle ragioni che possano aver spinto l’esecutivo a precisare solamente una soglia massima dell’importo di conversione, prefigurando quindi il concreto rischio di un’eccessiva discrezionalità nel delegato in punto di precisazione della soglia minima.
4. La successiva disposizione prevede nuove cause estintive delle contravvenzioni. Condivide la riforma e se sì non le pare però troppo timida: dalla lettura della lett. a) dell’art. 10 pare che la riforma non interessi le contravvenzioni punite con sola penadetentiva, si escludono le contravvenzioni connesse a delitti (lett. b), e per quest’ultimi non si è minimamente pensato a cause estintive.
Il Giudice: CONDIVIDO PIENAMENTE QUANTO INDICATO NEL PUNTO A), ASSICURANDOSI PERO’ L’EFFETTIVO PAGAMENTO, ANCHE TARDIVO, DELLA SOMMA DI DANARO, NONCHE’ IL CONTROLLO DELLA ESPLETATA PRESTAZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’. ANCHE LA LETTERA B) E’ CONDIVISIBILE, MA SEMPRE PREVIA PREVISIONE DI ADEGUATE SANZIONI “SOSTITUTIVE” E PREVIO CONTROLLO DELL’EFFETTIVA LORO INTEGRALE PRESTAZIONE. IN RELAZIONE ALLA LETTERA C), CONDIVIDO IL MANTENIMENTO DELL’OBBLIGO DI CUI ALL’ART. 347 C.P.P.. SAREBBE INFINE CERTAMENTE OPPORTUNA, COME GIUSTAMENTE INDICATO AL PUNTO D), LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE SINO ALLA CONOSCENZA DEL P.M. DELL’AVVENUTA EFFETTIVA PRESTAZIONE DELLE CONDOTTE RIPARATORIE; NOVITA’ ANCHE QUESTA DI ENORME VALORE DEFLATTIVO!
Il PM: Condivido questo aspetto della riforma che mira ad estinguere, già nella fase delle indagini preliminari, alcune fattispecie contravvenzionali secondo il meccanismo delineato nell’art. 10 lettera a) facendo rilevare che sarebbero interessati da siffatta modifica numerosi reati atteso che la maggior parte sono puniti con ammenda o con pena alternativa residuando poche ipotesi sanzionate con la sola pena detentiva. L'individuazione di un gruppo di reati contravvenzionali - così come indicato nella successiva lettera b) dell’art. 10 - in relazione ai quali, fermo restando per la polizia giudiziaria l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, il procedimento penale rimarràsospeso fino alla scadenza del termine che sarà concesso al contravventore per l'adempimento delle prescrizioni impostegli al fine di elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e per il pagamento di una somma di denaro (con possibilità, in alternativa, della prestazione di lavoro di pubblica utilità), ricalca un modello di estinzione del reato già sperimentato per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. Tale intervento consentirebbe, inoltre, di evitare al reo e al sistema giudiziario la celebrazione di un procedimento penale per reati meno gravi ogniqualvolta l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento di una sanzione pecuniaria o la prestazione di lavoro di pubblica utilità garantiscono in tempi rapidi il ripristino dell'ordine giuridico violato dall'illecito e l'eliminazione di ogni conseguenza dannosa, effettiva o potenziale, derivante dallo stesso.
L'Avvocato: Ancora una volta la montagna ha partorito il topolino; ciò sia in ordine alla selezione delle contravvenzioni - risultando francamente poco chiare le ragioni che hanno determinato l’esclusione delle contravvenzioni connesse a delitti – che in merito alla mancata previsione di un regime riparatorio/risarcitorio suscettibile di incidere anche con riferimento alla commissione di determinati delitti. L’aver previsto una procedura ad hoc – la sospensione del procedimento sino all’avvenuta comunicazione all’Ufficio del Pubblico Ministero dell’effettiva esecuzione delle attività poste a carico dell’indagato – si presta ad operare in chiave estintiva anche in ipotesi diverse da quelle meramente contravvenzionali, rappresentando uno strumento di tipo deflattivo utilizzabile a più ampio raggio.
Il Docente: La timidezza della riforma non è da ritenere, a questo punto, un grande segreto. Un progetto così esteso e articolato non sembra adeguatamente supportato da un programma sistematico sufficientemente edificato sul binomio inscindibile fra le criticità tecniche del processo e le lacune economiche e organizzative. Lo scopo dell’art. 10 proposto consiste evidentemente nell’introdurre una nuova causa di estinzione del reato contravvenzionale e non è un caso che l’esecutivo si riferisca espressamente alla fase delle indagini preliminari. Secondo gli scriventi, infatti, la modifica non può considerarsi sorprendentemente innovativa, ma non rappresenta altro che un disperato tentativo di inserire nell’ordinamento nazionale una parvenza di archiviazione condizionata. Spesso, si attribuisce tale connotazione a quegli espedienti giuridici che consentono il mancato esercizio dell’azione penale ovvero l’estinzione dell’imputazione dopo che sia stata formulata, nelle circostanze in cui la persona sottoposta alle indagini realizzi tempestivamente dei prescritti comportamenti positivi nei confronti della generalità dei consociati, al punto da renderla meritevole di beneficiare dell’esito liberatorio. Non è un caso che proprio nell’ordinamento processuale tedesco, anch’esso caratterizzato dall’obbligatorietà dell’azione penale, l’istituto dell’archiviazione meritata abbia avuto un esito più che positivo nello smaltimento del carico presente nelle aule di giustizia. Chiaramente, emulare il modello della Germania è un’opera a prima vista ambiziosa, ma certo non lo è fino in fondo se il bacino applicativo delle fattispecie a cui rivolgersi è così ristretto. Nel nostro ordinamento, per le ipotesi contravvenzionali già esistono i rimedi disciplinati dagli artt. 162, 162-bis e 162-ter c.p. Pertanto, ci si sarebbe aspettati una manovra sicuramente più audace, che potesse investire – con tutte le cautele del caso – anche talune fattispecie delittuose, senza aver timore di introdurre un’interpretazione dell’art. 112 Cost. che potesse far fronte, una volta per tutte, alle richieste di aiuto invocate dal nostro sistema processuale.